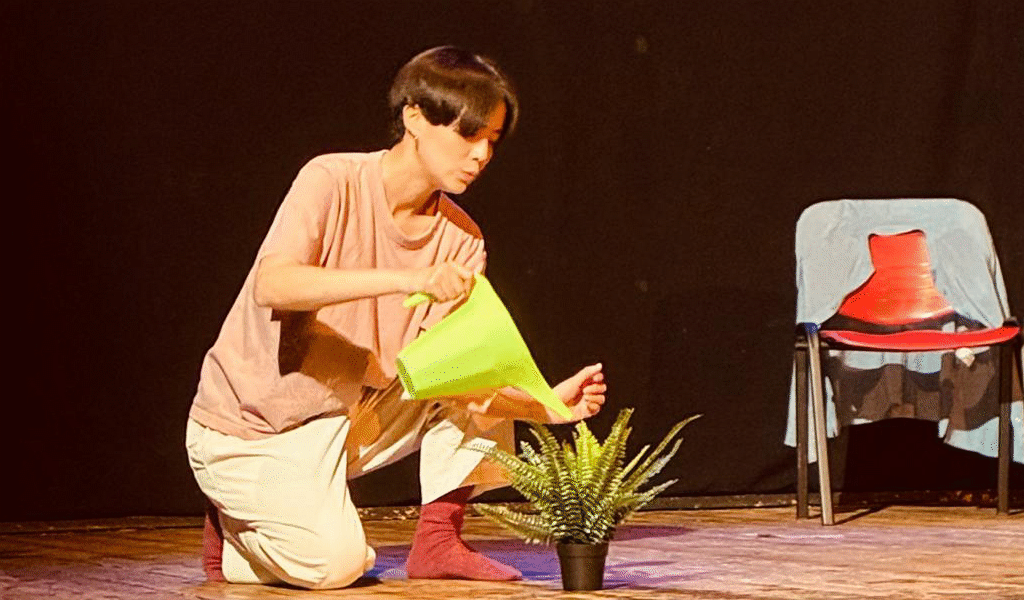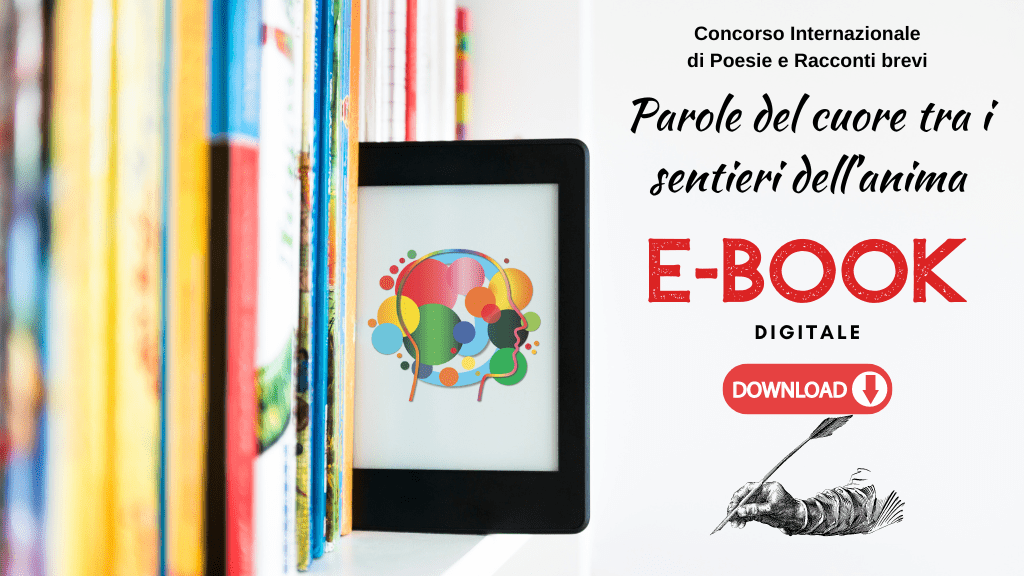Gian Paolo Mai ci racconta Brothers

Un testo che tra cronache e poesie racconta la guerra
Sarà in scena dal 2 al 4 maggio al Teatro Trastevere di Roma Brothers dai Balcani a Gaza (cronache e poesie di guerra) tratto dai testi di Faruk Šehić, Mahmoud Darwish e altre stanze con adattamento e regia di Gian Paolo Mai. Scrittori e poeti hanno da sempre affrontato questo argomento e in molti si sono ritrovati all’interno degli stessi conflitti che hanno insanguinato i paesi.
Cronache e testi hanno ricordato la crudeltà, il dolore e le perdite delle guerre, così com’è avvenuto anche con poeti e scrittori attuali, che utilizzano tutti i mezzi di comunicazione per raccontare ciò che ci circonda. È lo stesso Gian Paolo Mai che ha risposto ad alcune domande su un testo molto attuale e che dovrebbe scuotere gli animi delle persone ormai assuefatti da storie di guerre e morti, da stragi che si ripetono giorno dopo giorno.
Benvenuto. Sarà in scena con lo spettacolo Brothers Dai Balcani a Gaza (cronache e poesie di guerra). Poeti che hanno descritto la guerra, come in passato hanno fatto i loro predecessori, attraverso parole e poetica. Come vivono i tanti scrittori la guerra in prima linea?
La guerra, vissuta in prima linea dagli scrittori e dai poeti, diventa spesso una lente cruda ma profondamente umana attraverso cui raccontare l’orrore, la resistenza e la fragilità dell’essere umano. Autori come Faruk Šehić, che ha combattuto nella guerra in Bosnia, o Mahmoud Darwish, che ha vissuto l’esilio e la lotta palestinese, trasformano l’esperienza personale in poesia civile, capace di dare voce a chi non ha voce.
Per questi scrittori, scrivere non è solo un atto artistico: è un’urgenza. Una forma di sopravvivenza interiore. Le parole diventano rifugio, testimonianza, ma anche arma. C’è un profondo senso di responsabilità nel narrare ciò che si vive: la guerra li costringe a confrontarsi con la perdita, l’identità, il senso di appartenenza e spesso anche con il senso di colpa per essere sopravvissuti.
Darwish, ad esempio, usa una lingua lirica e colta per esprimere l’assenza, la terra perduta, il desiderio di libertà. Šehić, più diretto e brutale, mescola prosa e poesia per raccontare la disumanizzazione del soldato, ma anche la delicatezza di un fiore che cresce tra le macerie.
In scena, questi testi diventano cronache poetiche, immagini potenti che superano la cronaca giornalistica e toccano l’animo. Brothers – dai Balcani a Gaza diventa così un ponte di parole tra guerre diverse, ma unite dallo stesso dolore. Raccontare la guerra, per questi autori, è un modo per restare umani.
Dagli inizi del Novecento alle ultime guerre, soffermandosi a quella di Gaza oggi, che sta distruggendo un popolo. Com’è possibile che il mondo non si interroghi con maggiore attenzione su ciò che distrugge?
È una domanda che attraversa il secolo, e forse tutta la storia dell’umanità: com’è possibile che, pur avendo visto, letto, pianto, raccontato tanto orrore, si continui a ripetere la distruzione?
Dall’inizio del Novecento — con le trincee della Grande Guerra, l’orrore dei campi di concentramento, Hiroshima, i Balcani, il Rwanda — fino alla guerra in Gaza oggi, assistiamo a una sorta di assuefazione globale. Le immagini scorrono, i titoli si rincorrono, ma spesso manca il silenzio necessario per interrogarsi davvero, per ascoltare.
Viviamo in un’epoca in cui l’informazione è ovunque, ma la coscienza è sempre più dispersa. C’è una distanza comoda tra lo spettatore e il dolore dell’altro. Ma quando un popolo viene distrutto, come accade oggi a Gaza, il silenzio del mondo diventa complicità.
Eppure, i poeti e gli scrittori ci ricordano che ogni vita cancellata ha un nome, una storia, una poesia non scritta. Darwish diceva: “Scrivere è il mio modo di vivere e di morire allo stesso tempo.” E in queste parole c’è la chiave: la parola resiste, anche quando tutto crolla.
Il teatro, l’arte, la poesia – sono forse gli ultimi luoghi dove ancora si può sentire veramente. Dove non si cerca di semplificare, ma di restare dentro il dubbio, nella domanda. Forse il mondo non si interroga perché è più facile voltarsi dall’altra parte. Ma chi sceglie di ascoltare questi testi sceglie di non essere indifferente.

Nelle guerre chi paga le maggiori conseguenze sono i deboli, i bambini, gli anziani, la popolazione che è costretta a fuggire. Abbiamo la guerra a due passi, eppure ci siamo così abituati a viverla da essere messa in secondo piano. A cosa dobbiamo queste sensazioni che ci immobilizzano?
Queste sensazioni che ci immobilizzano – l’indifferenza, l’assuefazione, il senso di impotenza – nascono da una sovraesposizione al dolore e da una perdita di connessione reale con chi soffre. Vediamo tutto attraverso uno schermo: bambini sotto le macerie, anziani in fuga, madri che stringono i figli. Le immagini passano, scorrono, e poi arriva qualcos’altro. La velocità con cui consumiamo il dolore altrui ci rende spettatori anestetizzati.
A pagare il prezzo più alto delle guerre non sono mai i potenti, ma i corpi fragili, i volti senza nome: i bambini che non hanno avuto il tempo di diventare grandi, gli anziani che speravano almeno nella pace finale, le famiglie costrette a lasciare tutto. Sono loro i veri caduti della guerra, quelli che non finiscono nelle statistiche ma nella memoria di chi li ha amati.
Eppure ci siamo abituati a convivere con la guerra, anche quando è vicina, anche quando bussa ai confini dell’Europa o esplode nel cuore del Mediterraneo. Ci paralizza una sorta di impotenza collettiva, il timore di non poter cambiare nulla. Così preferiamo guardare altrove. È un meccanismo di difesa, ma anche una responsabilità mancata.
L’arte, il teatro, la poesia hanno ancora il potere di scuoterci, di riportarci dentro la verità nuda di questi eventi. Non per spiegare, ma per sentire. E forse, sentendo davvero, possiamo tornare a porci le domande giuste. Perché ciò che oggi sembra lontano può diventare, domani, il nostro stesso dolore.
Come sempre a contestare la guerra sono i giovani che, con il loro impegno per il futuro, provano a creare un mondo migliore, eppure chi sta al potere, gli adulti, sono stati i giovani del passato che hanno contestato le guerre nel mondo. Cosa non si è riusciti a comprendere della convivenza?
È uno dei paradossi più dolorosi della storia umana: i giovani che oggi sognano la pace sono gli adulti di domani che potrebbero dimenticarla. E gli adulti di oggi – che un tempo hanno marciato, scritto slogan, alzato la voce contro la guerra – ora spesso tacciono, o giustificano, o voltano lo sguardo. Cosa si è spezzato lungo il cammino?
Forse non si è riusciti a comprendere davvero la profondità della convivenza. Perché convivere non è solo tollerare l’altro, ma riconoscersi nell’altro. Significa accettare il conflitto come parte della relazione umana, ma scegliere ogni volta di risolverlo senza distruggere. E questo richiede ascolto, visione, e soprattutto memoria.
Chi ha vissuto la giovinezza in lotta per un mondo migliore dovrebbe essere il primo a custodire quella speranza. Ma spesso il potere logora, seduce, rende ciechi. I sistemi si ripetono, e chi entra nei palazzi finisce per proteggere ciò che ha conquistato, invece di aprire spazi nuovi.
Eppure, i giovani tornano, sempre. Sono loro il movimento, la voce scomoda, il battito del tempo che cambia. Contestano la guerra non solo per idealismo, ma perché la vivono sulla pelle, nei sogni rubati, nei coetanei che muoiono a migliaia in terre martoriate. Sono loro a ricordarci che un altro mondo è possibile, ma solo se chi ha già vissuto non dimentica com’era desiderarlo.
Forse la vera lezione che non abbiamo ancora imparato è che la pace non si conquista una volta per tutte: si costruisce ogni giorno, nella scuola, nella politica, nel linguaggio, nell’arte. E si trasmette come un testimone, senza spezzarlo.
All’interno del testo che porta in scena insieme a un cast di interpreti, ci sono molte voci anche di scrittori italiani, quali la Fallaci e Rodari, e molti altri. Cosa vuole far arrivare al pubblico?
Con questo spettacolo vogliamo far arrivare un grido corale, una testimonianza viva e necessaria, fatta di parole che attraversano il tempo, le lingue, i confini, ma che restano profondamente umane. Un coro di voci che racconta la guerra non solo come evento storico, ma come ferita dell’anima collettiva.
Portare in scena scrittori come Faruk Šehić o Mahmoud Darwish, accanto a figure italiane come Oriana Fallaci e Gianni Rodari, significa costruire un ponte tra mondi diversi, ma uniti da una stessa urgenza: dire la verità, anche quando è scomoda, anche quando fa male. La Fallaci ci interroga con la sua lucidità ruvida e impietosa; Rodari ci ricorda, con la forza della semplicità, che anche nella fantasia e nell’infanzia si annida una profonda richiesta di pace.
Vogliamo che il pubblico senta queste parole come proprie, che non restino letteratura o poesia da applaudire, ma esperienza viva da portare via con sé. Che possano far riflettere, far discutere, far tremare un po’ dentro. Perché, in fondo, lo scopo non è dare risposte, ma provocare domande.
In un’epoca dove la guerra sembra diventata uno sfondo abituale, vogliamo riportarla in primo piano, con la forza dell’arte e della parola. Far sentire che dietro ogni cifra, ogni notizia, ogni bombardamento, c’è un nome, un volto, una storia. E che restare umani, oggi, significa ascoltare, accogliere, interrogarsi. Anche scomodi, anche fragili. Ma presenti.

Lo spettacolo non è solo narrazione di parola, ma anche di immagini e prende spunto da un cortometraggio, Brothers prodotto da Libera Film Academy, vincitore di vari festival. Com’è avvenuta la trasposizione teatrale?
La trasposizione teatrale di Brothers nasce da un’esigenza profonda: dare corpo e voce a quelle immagini, a quei volti, a quei silenzi che nel cortometraggio scorrono come ferite aperte. Il film, prodotto da Libera Film Academy e premiato in numerosi festival, è stato il punto di partenza – un seme visivo ed emotivo – da cui è germogliato il lavoro teatrale.
Portarlo in scena ha significato trasformare il linguaggio del cinema in presenza viva. Non una semplice trasposizione, ma un’estensione: le parole si sono intrecciate alle immagini, le immagini alle voci, creando un’esperienza che non si guarda soltanto, ma si attraversa.
In teatro, ogni gesto è irripetibile, ogni sguardo è condiviso con lo spettatore in tempo reale. Per questo abbiamo voluto che il cortometraggio diventasse un elemento narrativo integrato: proiezioni che si fondono con le voci degli attori, immagini che dialogano con i testi di Darwish, Šehić, Fallaci, Rodari e altri. Il risultato è una drammaturgia mista, dove parola e immagine si completano, si sfidano, si amplificano.
Il passaggio dal cinema al teatro è stato anche un ritorno all’essenziale: al corpo, alla voce, alla presenza. In scena, l’emozione non è mediata, è lì, davanti agli occhi del pubblico. È proprio questa fragilità, questa verità, che abbiamo voluto conservare e amplificare rispetto al film
Qual è la forza del cortometraggio e quindi dello spettacolo?
La forza di Brothers – sia nella sua forma cinematografica che teatrale – sta nella sua capacità di umanizzare la guerra, di restituire un volto, una voce e un’anima a ciò che spesso viene ridotto a numero, statistica, rumore di fondo. È un’opera che non urla, ma sussurra con forza, e proprio per questo colpisce nel profondo.
Nel cortometraggio, la potenza risiede nelle immagini essenziali e nei silenzi: tutto è trattenuto, sospeso, e lascia spazio all’interpretazione emotiva dello spettatore. Non c’è spettacolarizzazione del dolore, ma un’intimità narrativa che avvicina, che fa immedesimare. Il conflitto non è raccontato solo come evento storico, ma come lacerazione interiore, come trauma che si riflette nei rapporti umani, negli sguardi, nei piccoli gesti.
Nello spettacolo teatrale, questa forza si amplifica. La parola – poetica, politica, viva – si unisce all’immagine e alla musica per creare una trama emotiva e collettiva. Il pubblico non assiste, partecipa. Viene chiamato in causa, interrogato, anche nel silenzio
Cosa è possibile sperare per il nostro mondo?
È possibile sperare che l’arte continui a resistere, a raccontare, a porre domande. Che la memoria non venga messa da parte, e che il dolore degli altri torni a toccarci come fosse il nostro. È possibile sperare che i giovani non smettano mai di sognare un mondo diverso, e che gli adulti imparino a non tradire quei sogni.
Possiamo sperare in una nuova forma di umanità, più attenta, più lenta, meno distratta. Una società che non si abitui al rumore della guerra, che non si rassegni alla logica della forza, che non trasformi il dolore in abitudine.
E se questa speranza sembra fragile, allora affidiamola alle parole, alla poesia, alla scena, a quelle piccole luci che non fanno rumore ma che resistono al buio. Perché finché c’è qualcuno disposto ad ascoltare, a raccontare, a ricordare, non tutto è perduto.
Grazie e in bocca al lupo!