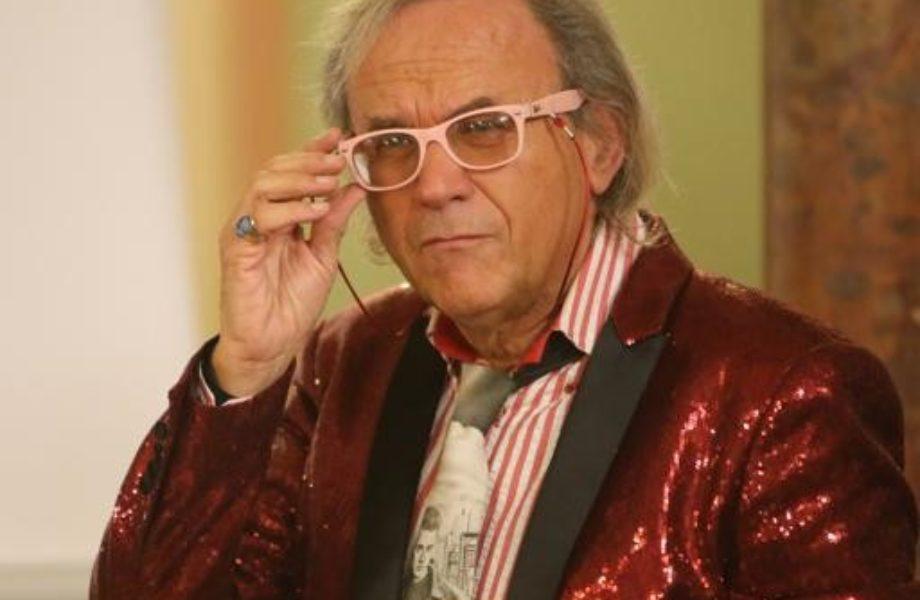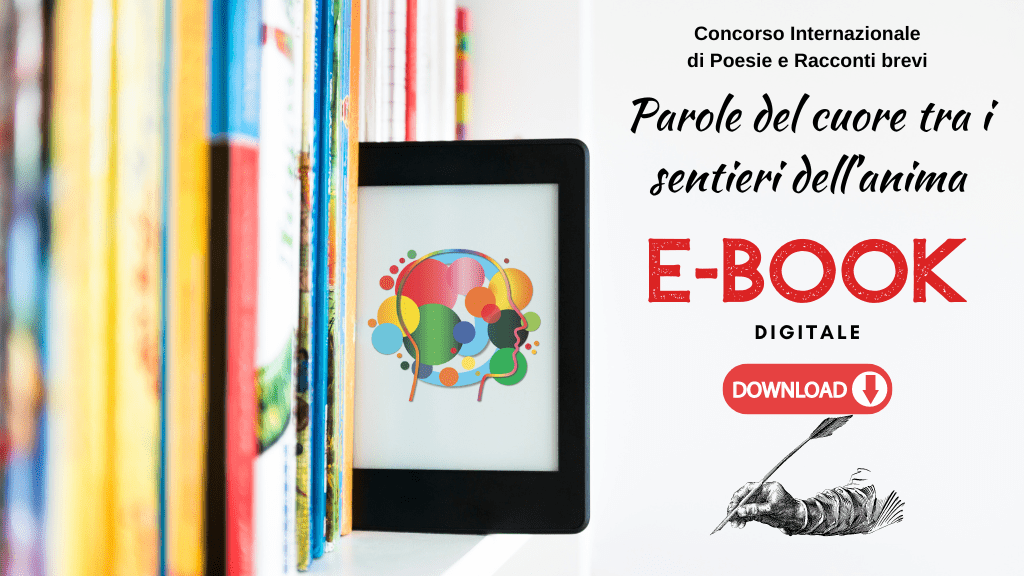Lia Tagliacozzo: La generazione del deserto

“noi siamo nati con una gravante addosso: quello cioè di “meritarci” questa sopravvivenza”
Con il passare degli anni il calendario assume sempre più l’aspetto di un memoriale giornaliero, potremmo dire un calendario civile, dove quasi ogni giorno, finisce per farsi memoria di un avvenimento: la giornata del migrante, quella delle donne vittime di femminicidio, ecc.. Ma su tutte sicuramente quella che ha assunto valore paradigmatico è il “giorno della memoria” che cade il 27 gennaio di ogni anno, a ricordare l’entrata dell’Armata Russa nel campo di sterminio di Auschwitz. Intorno a questa data scrittori e poeti, per non parlare di storici, hanno scritto pagine e pagine dove hanno raccontato storie, non solo quelle fatte di grandi numeri, la “grande storia”, ma le storie delle persone e dei luoghi dove quei fatti si sono svolti. I testimoni di quel periodo con il passare degli anni vengono sempre meno e allora ecco l’importanza della “tradizione”, di quel termine latino tràdere, che vuol dire consegnare, trasmettere. In occasione del 27 gennaio “giorno della memoria”, vengono pubblicati diversi libri sia di carattere storico che di testimonianza personale che ci “consegnano” storie di “giusti e di infami”. Il libro di Lia Tagliacozzo “La generazione del deserto” edito da Manni, nel 2020, racchiude la storia di una famiglia raccontata sullo sfondo della grande storia, a partire da quel 16 ottobre 1943 quando la vita del popolo ebraico romano subì la “razzia”. Un libro che racconta storie di famiglia, di giusti ed infami durante il periodo delle leggi razziali in Italia, una storia che si muove fra Roma, Firenze e la Svizzera. Un libro che vuole essere una riflessione su tema della responsabilità di chi visse, ma erano tutte “persone normali” non certo “eroi” (pa.56) allora “davvero in tempi bui” (Bertold Brecht) e chi oggi ha il dovere di raccontare perché la memoria, con il venir meno dei testimoni, non si annebbi per essere dimenticata o negata del tutto.
Ma oggi che il tempo trascorso mette una distanza di due generazioni, quella dei nonni e quella dei padri, con i fatti accaduti allora, ci obbliga a rispondere alla domanda: il tempo del lutto (pag. 63) è finito? Siamo finalmente entrati come generazione dentro una “memoria civile” in cui il pianto e il dolore sono rinchiusi dentro la sfera personale, che ci permette oggi di raccontare quello che è stato un periodo della nostra storia, in cui morte e distruzione hanno attraversato le nazioni europee. I nostri padri e i nostri nonni si sono spesso chiusi nel silenzio e nel dolore. A noi figli spesso è toccato raccontare una storia non nostra. Tagliacozzo fin dalle prime pagine si chiede “Che razza di storie si possono raccontare? Si può scrivere di paure non nostre? Di vite non nostre? Con quale legittimità? Siamo una generazione di nati nel viaggio, siamo clandestini alla vita, sospesi a metà, nati dopo la schiavitù e prima della libertà. Siamo senza voce e con una storia nostra ancora da inventare. Ma la vita la stiamo vivendo e avremo qualcosa da dire. Siamo la generazione del deserto, frutti dalla maturazione lenta, fioriamo dopo i quaranta anni” (pag. 13).
Due parole colpiscono “viaggio” e “deserto”. E il libro di Tagliacozzo è un viaggio attraverso il deserto dentro un secolo tragico fatto di idolatria, angoscia e paura, in cui gli uomini anche quelli più forti sono stati tentati nella fede, quando non l’hanno persa. Dove la Legge “Amerai Dio con tutto il tuo cuore…” si è persa nelle tenebre. E allora il deserto, che questa generazione, la nostra generazione, ha attraversato, è un cammino che ritroviamo nell’Esodo, è la marcia che il popolo di Dio ha intrapreso dalla schiavitù d’Egitto e dei suoi “idola” verso la terra promessa. I russi chiamano il deserto “pustinia” che non è solo un luogo geografico, ma anche eremo, un luogo tranquillo dove ci si ritira per trovare Dio, un luogo dove riparare i propri peccati e quelli dei fratelli. “Il deserto è il luogo dove possiamo riprendere coraggio, dove pronunciare le parole della verità ricordandoci che Dio è verità. Il deserto è il luogo dove ci purifichiamo e ci prepariamo ad agire come toccati dal carbone ardente che l’angelo pose sulle labbra del Profeta” (Caterina de Hueck Doherty).
A chi le chiede perché “La generazione del deserto” Lia Tagliacozzo risponde che “Quella del deserto è la mia generazione, i cui genitori erano bambini durante la guerra. Noi siamo i “nati dopo il passaggio del Mar Rosso”, siamo quelli che prima di arrivare alla Terra promessa devono ancora attraversare il deserto. Per arrivare alla libertà ci vogliono 40 anni di peregrinazioni. Noi siamo nati sì liberi, quando tutto era finito, ma dentro le nostre famiglie non era finito niente. Le ferite erano ancora vive. La generazione del deserto è sopravvissuta ad un progetto sistematico ed industrializzato di sterminio nella misura in cui sono sopravvissuti i nostri genitori. Loro sono sopravvissuti per caso, come tutti gli ebrei usciti vivi dalla seconda guerra mondiale, e quindi noi siamo nati con una gravante addosso: quello cioè di “meritarci” questa sopravvivenza, e di essere degni alla sopravvivenza a cui le nostre famiglie avevano avuto accesso, non per merito, ma appunto, per caso”. In queste parole ritornano i tanti pensieri troppo volte ascoltati sul senso di colpa, sul caso, sul peso di una vita “salvata” che per molti diventa insostenibile, come per Primo Levi. “Adesso mi rendo conto che loro, tutti loro, per il solo fatto di essere vivi erano dei sopravvissuti” (pag. 86).
Il racconto poi è attraversato da quello che viene chiamato la “congiura del silenzio”. Un silenzio tenuto per proteggere gli altri e per proteggere se stessi. “La congiura del silenzio infatti è amore reciproco: dei genitori per i figli e dei figli verso i genitori” (pag. 42). I genitori non raccontavano, ma i figli non chiedevano. A tanti della mia generazione è accaduto. Mio padre solo dopo cinquant’anni ha raccontato di aver comandato un plotone di esecuzione da militare e partigiano contro due spie italiane che lavoravano per i nazifascisti, gli infami di cui anche il libro di Tagliacozzo ci racconta. Io non ho mai chiesto nulla del periodo della guerra e soprattutto di quei venti mesi di “guerra civile” che ha visto italiani contro italiani. Mio padre non ho mai voluto raccontare nulla. E’ morto portandosi via i suoi segreti. E il suo silenzio come quello di mia madre, come quello dei genitori di Lia, era una forma di protezione nei riguardi di noi figli.
Il libro di Tagliacozzo è un libro di ricordi. Ma ricordare non è sufficiente. Primo Levi scrive che “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. E solo lo studio della Storia può creare quegli anticorpi democratici che ci permettono di comprendere che oggi il tema del fascismo va posto in relazione alla evidente crisi della democrazia e delle sue istituzioni. La crisi economica dal 2008 ad oggi ha fatto sì che la democrazia non venga avvertita più come un valore fondamentale. Il fascismo, non solo quello macchiettistico della camicia nera e del fez, ma quello ben più preoccupante, il fascismo eterno, come lo definisce Umberto Eco, che assume i caratteri odierni del razzismo, della xenofobia, dell’antisemitismo, è visto come un fenomeno lontano e la sua paura non fa più presa. Certe manifestazioni con evidenti simbologie fasciste e naziste vengono spesso catalogate come “goliardia”. Stanno quindi venendo meno tutti gli anticorpi nei confronti dei possibili pericoli per la democrazia, che nessuno oggi può prevedere, pericoli che però vediamo aleggiare nella società, spesso amplificati dai social, come gli episodi di zoombombing, che recentemente hanno colpito proprio Lia Tagliacozzo, un cognome che è garanzia di ebraismo e della sua tragedia, durante la presentazione on line del suo libro “La generazione del deserto”. Ma Lia non si è fatta intimorire ma ci ha invitato ad andare avanti, a continuare a vaccinarci contro il virus dell’odio. E il nostro vaccino si chiama “Costituzione”, per i cui ideali antifascisti, democratici, di libertà e di uguaglianza la famiglia di Lia Tagliacozzo, come tante altre famiglie ebree e non solo, hanno pagato un contributo di sangue. E perché il loro sacrificio non risulti vano occorre sempre tenere presente che non ci vuole niente a diventare ostaggi di logiche distruttive e perché “Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo” (Anna Frank).
Un altro tema del libro che stimola una riflessione è quello del “perdono”. Una richiesta che spesso sentiamo fare per chiudere i conti con il passato. Liliana Segre ci ricorda che “No, non ho perdonato, non è possibile, e non ho mai dimenticato, ma ho imparato a non odiare… Ma quando ebbi la possibilità di prendere la pistola e sparare all’ufficiale tedesco non lo feci. E quello è stato il momento in cui ho capito che non ero come i miei assassini ed è stato lì che sono diventata la donna libera e di pace con cui ho convissuto fino ad oggi”.
La Shoah è un crimine troppo grande per essere perdonato “un crimine contro l’umanità sul corpo degli ebrei” (Hannah Arendt). I nazisti e i fascisti hanno superato abbondantemente il limite della “perdonabilità”. Solo chi ha subito un’offesa può perdonare, e la maggior parte delle vittime sono morte. Il perdono operato da terzi non può sostituire quello delle vittime. Emmanuel Levinas ci ricorda che “La responsabilità dell’uomo verso l’uomo è tale che Dio non può annullarla” e ancora con le parole del maestro rabbinico “la colpa commessa verso Dio ha a che fare con il perdono divino, la colpa che offende l’uomo non ha a che fare con Dio… Il male non è un principio mistico che si può cancellare con un rito: è un’offesa che l’uomo fa all’uomo. Nessuno, nemmeno Dio, può sostituirsi alla vittima. Il mondo in cui il perdono è onnipotente diviene inumano”
(Emmanuel Lévinas, Difficile libertà, Jaca Book, Milano 2004)
Nel libro storia e memoria, due facce della stessa medaglia, si inseguono, spesso si sovrappongono e compito dello scrittore è quello di raccontare storie, storie di persone e storie di luoghi, dando voce ai testimoni, fino a quando ne avremo la possibilità. Ma su tutto è necessario che di quelle storie e di quei luoghi se ne parli con le nuove generazioni, perché comprendano che quella storia è la nostra storia, dentro quella storia e quei luoghi ci sono le radici dell’oggi, perché quello che è successo potrebbe succedere nuovamente.
E allora come dice Lia “Serve una memoria che ha sempre più necessità di rivolgersi ai piccoli ricordi, alle storie apparentemente ordinarie, e non ai grandi proclami. La memoria ha bisogno del gerundio – rammemorando; è solo se continuamente compientesi, e mai atto compiuto. Richiede sforzo di cuore, ri-cor-dare, e di testa, ram-ment-are”
Lia Tagliacozzo. Scrittrice italiana (Roma 1964). Figlia di due sopravvissuti alla Shoah, esperta di cultura ebraica, collabora con diverse testate, tra cui Il Manifesto e Confronti. Ha lavorato nel settore culturale delle istituzioni ebraiche e si è dedicata alla divulgazione in particolare dell’ebraismo e della Shoah, partecipando a incontri con gli studenti nelle scuole e attraverso i suoi libri rivolti soprattutto ai bambini e ai giovani. Tra questi: Anni Spezzati (insieme a Lia Frassineti), Giunti, 2009, Il mistero della buccia d’arancia (2017), La Shoah e il Giorno della Memoria (2017) e La generazione del deserto. Storie di famiglia, di giusti e di infami durante le persecuzioni razziali in Italia (2020).