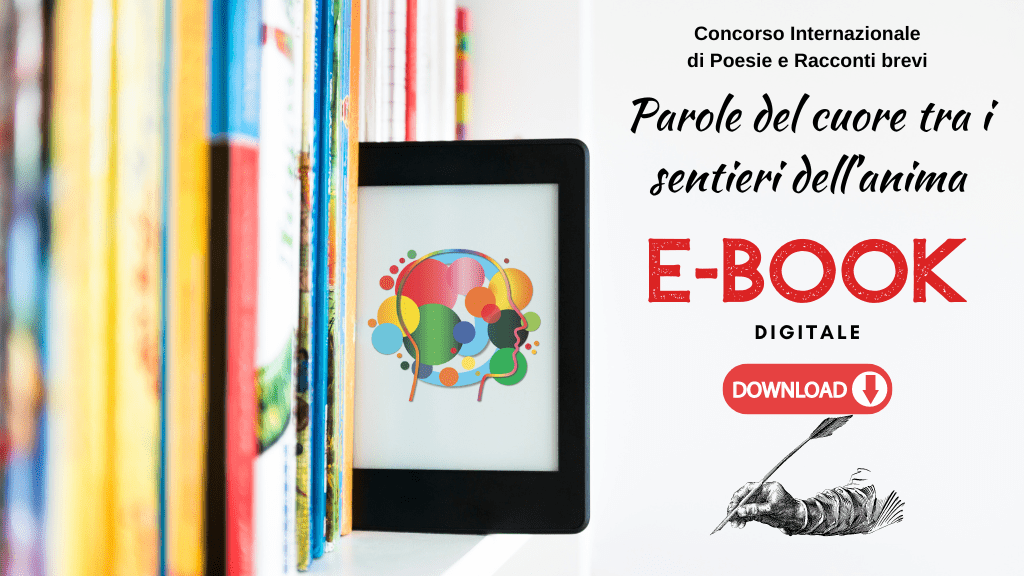Progetto Auschwitz: la banalita’ del male

Noi dimostreremo che questi uomini sono simboli viventi degli odi razziali
Al termine della rappresentazione “Progetto Auschwitz” di e con Poerio Lulli e la compagnia L’Allegra Brigata, in palcoscenico questo fine settimana all’Auditorium Pierluigi di Palestrina, dopo un primo memento di “silenzio interiore” mi sono chiesto: ma saprei, o meglio sapremmo, riconoscere il fascismo e le sue tragiche conseguenze se si ripresentasse nuovamente davanti a noi?
La risposta mi è arrivata riprendendo in mano il libro di Abert Camus “La Peste”, un libro scritto nel 1947, a ridosso della fine della seconda guerra mondiale e della “scoperta” degli orrori della Shoah. Un libro che torna oggi utile per capire il nostro presente in un momento in cui l’inferno del passato si ripresenta in varie parti di Europa e anche qui in Italia abbiamo segnali preoccupanti di un risorgere di sentimenti antisemiti (il Jude Hier di Mondovì) e razzisti (dallo “sporco negro” a “negro di merda”). La Peste di Camus è un’allegoria della genesi del fascismo, visto come un morbo (la peste) di cui all’inizio si sottovaluta la gravità che poi porterà al diffondersi dell’epidemia in forme estremamente gravi. Noi oggi, nel Giorno della Memoria ricordiamo, ma con il rischio di farne una ritualizzazione banalizzante. L’Allegra Brigata ci ha messo davanti non solo gli orrori, a cui ebrei, handicappati, omosessuali, rom, politici furono sottoposti, ma con l’atto di accusa al Processo di Norimberga ci ha richiamato tutti a non abbassare la guardia, a non rimanere indifferenti di fronte al diffondersi dell’epidemia, a non avere indecisioni di sorta nel riconoscere la “malattia”. Il nazifascismo fu una epidemia che si diffuse senza prendersi pause. In Italia dal 1922 al 1938 i segnali furono tanti, ma molti li negarono, altri li sottovalutarono, altri rimasero indifferenti, chi ne vide i pericoli pagò con la vita come Matteotti e i fratelli Rosselli.
Quando la pubblica accusa afferma “Noi dimostreremo che questi uomini sono simboli viventi degli odi razziali, del terrorismo e della violenza, dell’arroganza e della ferocia del potere. Sono gli emblemi di una nazionalismo e di un militarismo violento……” è come se parlasse oggi a noi. A noi che dopo la Shoah abbiamo dimenticato i genocidi degli ultimi ottant’anni e che “Progetto Auschwitz” ci ha ricordato al termine della rappresentazione. Genocidi che non sono certo terminati in Medio oriente, in Africa, in America latina dove ancora oggi uomini e donne soffrono e muoiono perché diversi per etnia, per religione o semplicemente perché hanno la sfortuna di nascere nel posto “sbagliato”.
L’Allegra Brigata, nel nome l’ironia di un destino, con una recitazione a tratti estraniante, propria del teatro epico brechtiano, coinvolge lo spettatore fino a farne destinatario attivo. Ha colpito il silenzio con cui gli spettatori hanno seguito il “dramma”, inchiodati sulle poltrone, come se al posto dell’attore ci fossero loro, e provassero sulla loro persona tutta l’oscenità di ciò che veniva rappresentato. Gli attori, tutti “stupendamente” non professionisti, mostravano i loro personaggi e invitavano lo spettatore a porsi in una posizione di critica di ciò che veniva rappresentato. L’attore colloquia con il pubblico e lo induce a giustificare o rifiutare e comunque a prendere posizione rispetto a quello che vede: non può e non deve rimanere indifferente.
Poerio Lulli ha diretto un gruppo di “non attori” immaginando che in quelle scene ci fossero Avraham, Chana, David, Moshè, Miriam, uomini e donne nostri vicini, nostri amici, nostri parenti che l’ignavia, la paura, il credere nel duce o nel fuhrer, hanno consegnato nelle mani dei carnefici che erano a loro volta uomini e donne nostri vicini, nostri amici, nostri parenti.
Il rischio oggi è che variamente riverniciato e aggiornato a nuovi miti che si chiamano “sostituzione etnica”, “invasione”, “primatismo”, “sovranismo”, il fascismo, magari con un nuovo nome, torni a ripresentarsi sul palcoscenico della storia e appaia a uomini e donne accettabile e rispettabile. E’ quello che accadde a partire dagli anni venti del novecento e per una strana combinazione del destino oggi all’alba degli anni venti del duemila al posto della frase di Karl Marx “La storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia e la seconda come farsa” è forse più giusta quella di Eugenio Montale: “La storia non è magistra di niente. Accorgersene non serve a farla più vera e più giusta”.
Poerio Lulli con “oratorio per un olocausto” ha inteso metterci in guardia sul pericolo che “le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso” (Hannah Arendt: La banalità del male).