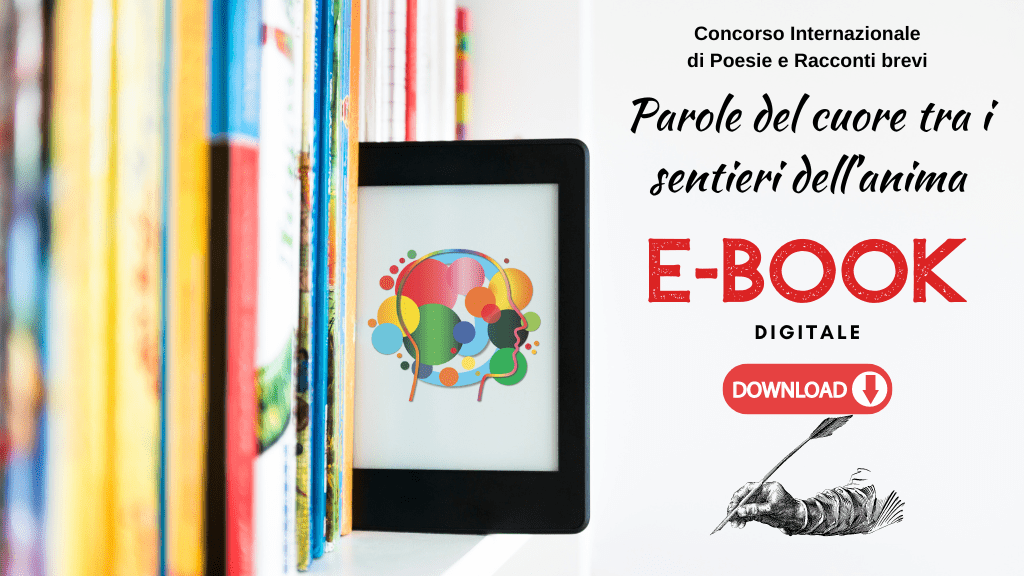Tre generazioni di donne per cambiare la storia

Al Teatrosophia ritorna lo spettacolo Herbarie, le chiamavano streghe
Al Teatrosophia di Roma dal 16 al 18 febbraio, torna lo spettacolo Herbarie, le chiamavano streghe di Silvia Pietrovanni, regia di Ivan Vincenzo Cozzi, con Brunella Petrini, Elena Stabile e Silvia Mazzotta, adattamento di Silvia Mazzotta.
Uno spettacolo che, attraverso tre generazioni, racconta la figura delle herbarie all’interno della nostra storia e società, considerate dalla gente del popolo sagge, dal potere, invece, streghe e ciarlatane. Una contraddizione che ha sempre seguito la figura femminile che riusciva a contraddistinguersi nel mondo maschile.
Le donne che attraversano la storia, hanno da sempre dovuto lottare per veder riconosciute le proprie capacità, conoscenze e attitudini. In questa drammaturgia si vuole ricordare il passato, osservare il presente e guardare il futuro, che porterà il cambiamento nella storia. Ne ho parlato insieme al regista della pièce Ivan Vincenzo Cozzi.
Ritorna in scena Herbarie. Le chiamavano streghe, un testo che parla dell’erborista del popolo. Come sono viste le tre figure che rappresentano le herbarie?
Sono tre personaggi: nonna, madre e figlia. Tre età, tre attitudini, tre generazioni di donne che vivono tramandandosi la cultura e la sapienza erboristica. Il loro fine, la loro vocazione è quella di offrire alla gente delle campagne che non potrebbe avere accesso alle cure ufficiali, la possibilità di guarire dalle malattie, di essere assistite nelle nascite e nelle morti grazie ai rimedi estratti dalle piante, dai fiori e dalle erbe.
Le tre donne attraversano un periodo di vita comune che verrà cambiato dagli eventi che le singole herbarie affronteranno con il cambiamento epocale.
Tre donne, tre storie: cosa le accomuna o le rende particolarmente diverse?
Le tre donne fino ad un certo punto hanno una sola storia, quella di una famiglia dedita alla cura. La loro vita cambierà nel momento in cui la medicina ufficiale diventerà, con l’appoggio della Chiesa, l’unica ammissibile.
Mercuria, Caterina e Lucia diventeranno: una, la più anziana, l’oggetto della persecuzione dell’Inquisizione; la più giovane, invece, si rifugerà in un convento dove potrà continuare il suo lavoro di herbaria, mentre la madre fuggirà, rifugiandosi nelle campagne e continuando a portare la sua cura
Le accomuna la loro vocazione; le rende diverse il succedersi degli eventi.
Sagge e streghe, la cultura le denomina in maniera totalmente opposta. Come vivevano realmente il loro ruolo e con quali sentimenti affrontavano le persone che incontravano?
Nel momento in cui viene deciso che solo la medicina ufficiale è praticabile, è l’Inquisizione, tribunale nato per trovare, torturare e condannare chi curava con le erbe e con ritualità non riconosciute dalla Chiesa, a nominare le donne che si adeguino alle normative o che proseguano nelle loro modalità di vita.
Come abbiamo accennato, le dominae herbarum erano le uniche referenti per la cura dei ceti più poveri; avevano uno scambio molto diretto con le persone che incontravano, erano sempre a disposizione per risolvere sia i problemi di salute, sia quelli più interiori. In cambio non chiedevano denaro. Chi poteva offriva loro cibo o altre ricompense oppure barattava le conoscenze.
Oggi il loro è un lavoro riconosciuto, quello delle farmaciste, ma è davvero così?
L’attuale lavoro della farmacista non è lo stesso che hanno esercitato le herbarie nelle diverse epoche. Sarebbe più simile il lavoro di erborista, ma ancora oggi l’erboristeria, le cure con elementi naturali, quanto meno non vengono riconosciute.
In particolare l’erboristeria – nel corso di laurea in farmacia del nostro ordinamento – si limita ad un unico esame di base. Tutto il resto non viene preso in considerazione.

Registicamente come ha affrontato lo spettacolo?
Ho affrontato lo spettacolo prendendo in esame i molteplici documenti sia di medicina popolare, sia dei processi dell’Inquisizione, che avrebbero potuto aiutarmi ad entrare in sintonia con i vari argomenti trattati nel testo e per poter avere elementi precisi e veritieri attraverso cui raccontare.
In particolare ho approfondito testi e libri che parlavano del tipo di vita che si conduceva allora, della solidarietà concreta ed empatica che le donne riuscivano a mettere in campo sinergicamente quando veniva richiesta loro una cura e, soprattutto cercando di valorizzare quelli che erano gli aspetti ancora oggi importanti, di quel tipo di vita.
Quale parte dello stesso, ha richiesto maggior attenzione registica e perché?
La parte più complessa è stata sicuramente quella dell’interrogatorio e della persecuzione di Mercuria. Per poterlo rendere credibile, non scontato né banale relativamente soprattutto alle torture fisiche e psicologiche che venivano inflitte.
Come reagiscono gli spettatori al temine della rappresentazione? Quali sono i loro commenti?
Nelle edizioni precedenti abbiamo spesso chiesto agli spettatori di rimanere per parlare delle loro impressioni sullo spettacolo. C’è sempre stato molto interesse e molta voglia di confrontarsi. La reazione più evidente degli spettatori è l’aver scoperto da un lato l’attualità reale della storia e il grande divario che c’è fra la sapienza delle donne dell’epoca e la carenza di conoscenza che oggi ci costringe a delegare le cure ai medici e l’attenzione alla propria salute e a quella degli altri.
Un messaggio che ci fa piacere portare è che oggi c’è una reale volontà di riappropriazione e di conoscenza della salute, dello star bene e della cura.
Grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo!